Koinonia Novembre 2023
LA
BALLATA DEI DESTINI INCROCIATI
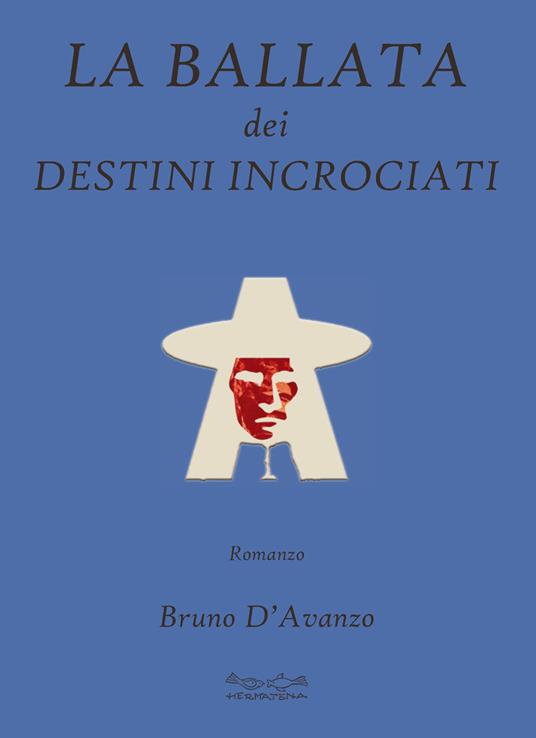
Prefazione
Nel dicembre del 1996 una quindicina di guerriglieri del Movimento Rivoluzionario Túpac Amaru (MRTA) del Perù sequestrarono tutti coloro che si trovavano nell’ambasciata giapponese della capitale, Lima.
Tra i prigionieri, oltre settecento, c’erano ministri peruviani, generali e anche numerosi ambasciatori di paesi esteri.
Il capo dell’operazione, denominata “rompere il silenzio”, si chiamava Néstor Cerpa Cartolini (comandante Evaristo).
In quegli anni presidente della repubblica era Alberto Fujimori, peruviano di origine giapponese che, assertore dei principi del neoliberismo, aveva messo in atto una politica di abbattimento dello stato sociale, peggiorando così le condizioni di vita di gran parte della popolazione. Di fonte alle proteste popolari, aveva risposto con una violenta repressione: incarcerazione di migliaia di oppositori, molti omicidi e sparizioni forzate. Mentre l’esercito combatteva con ogni mezzo i “maoisti” di Sendero Luminoso, noti per la loro ferocia, con altrettanta violenza colpiva le masse contadine, accusate di fiancheggiamento.
Il MRTA non aveva nulla a che fare con Sendero Luminoso, di cui condannava i metodi di lotta, e non ricorreva ad atti di terrorismo nei confronti della popolazione civile. Tuttavia era combattuto dal governo con gli stessi metodi.
Al momento del sequestro i guerriglieri avevano avanzato richieste precise per la liberazione degli ostaggi: che venissero rilasciati quattrocento prigionieri politici, tra i quali la moglie dello stesso Cerpa Cartolini; che i ribelli, dopo il rilascio dei sequestrati, potessero raggiungere la foresta peruviana portando con sé alcuni ostaggi che sarebbero stati poi liberati quando i guerriglieri fossero stati al sicuro. Gli insorti chiedevano inoltre un cambiamento radicale per quanto concerneva gli indirizzi economici e sociali del governo.
Al di là di queste richieste, tuttavia, un obiettivo fondamentale dei rivoluzionari era quello di attirare l’attenzione dei media internazionali sulle condizioni penose in cui era costretta a vivere gran parte della popolazione del Perù, schiacciata da una élite oppressiva con a capo un dittatore che si faceva chiamare presidente.
Le trattative proseguirono per quattro mesi. Fin da subito vennero rilasciati donne e anziani e pochi giorni dopo la maggioranza degli altri prigionieri. Il 22 dicembre ne restavano solo settantadue che avevano a che fare col governo Fujimori.
Quando riacquistarono la libertà, a fine aprile dell’anno successivo, tutti i sequestrati dissero di essere stati trattati bene per tutto il periodo della loro detenzione. Cinquanta di loro avevano chiesto addirittura un autografo al comandante Evaristo.
Durante quei quattro mesi diverse persone, tra cui il vescovo di Lima che aveva il permesso di celebrare messa, poterono entrare ed uscire dall’ambasciata. Questo diede modo alla polizia, che aveva avuto così l’opportunità di introdurre delle microspie, di sapere quello che succedeva all’interno dell’edificio.
Quando tutto lasciava pensare a un esito positivo della vicenda, il 22 aprile del 1997 centinaia di poliziotti delle forze speciali fecero irruzione proprio al momento in cui nel cortile alcuni guerriglieri erano impegnati in una partita di calcetto.
I ribelli, in gran parte ventenni, molti dei quali disarmati, vennero tutti uccisi. Eppure nessuno di loro si fece scudo dei prigionieri. Vennero trucidate a sangue freddo anche due ragazzine di quindici e sedici anni. Morì pure uno degli ostaggi, un membro della corte suprema, ma le pallottole che gli trovarono in corpo erano quelle in dotazione alle forze speciali. In un primo tempo fonti governative dissero che era stato ucciso dai guerriglieri per vendetta. Di fronte alla palese infondatezza di questa tesi fu detto poi che la sua morte era dovuta a un semplice errore. Tale ipotesi lasciò comunque dei dubbi, dal momento che il magistrato (unica vittima fra i sequestrati) era un noto avversario politico del presidente.
All’epoca fui molto colpito da quella tragica vicenda di cui parlarono per giorni i media di tutto il mondo, i quali denunciarono l’efferatezza dei corpi speciali e la responsabilità del presidente quale mandante dell’eccidio.
Quattro anni prima, a Firenze, avevo fondato il Centro Studi America Latina, che esiste tuttora, di cui ero anche il direttore. Fu per quel motivo, io credo, che un’associazione per i diritti umani di Pistoia mi chiese di tenere una conferenza su quei fatti a pochi giorni dall’eccidio. Giornalisti che avessero seguito da vicino quell’evento o studiosi della realtà politica del mondo andino avrebbero potuto intervenire sull’argomento con ben più titoli di me.
In altre situazioni avrei declinato l’invito, ma in quel caso decisi di accettare. Ero troppo coinvolto emotivamente e volevo confrontarmi, a caldo, con chi certamente aveva vissuto quell’episodio in un modo simile al mio.
Quando oggi, a distanza di tanti anni, ho occasione di parlare di quei fatti anche a persone interessate alle questioni dell’America Latina contemporanea, mi accorgo che i ricordi sono molto sfuocati. Forse anche per questo ho pensato di scrivere un romanzo ispirato a quelle vicende. Non un saggio, intendetemi bene. Che avrei io da aggiungere agli studi che hanno fatto sull’argomento numerosi storici? Ma un romanzo, un’opera di invenzione, è un’altra cosa: anni diversi, personaggi diversi, nomi diversi, storie personali di pura invenzione. Non mi si critichi, dunque, se non rispetto la verità storica di fatti, luoghi e situazioni.
Nel mio scritto le vicende politiche si mescolano a quelle private, personali, affettive dei personaggi, in un intreccio che si snoda sull’arco di una cinquantina d’anni. Non si meravigli il lettore se nell’ultima parte del romanzo parlo di episodi del 2040, successivi di quasi venti anni rispetto all’epoca in cui stiamo vivendo oggi. Questa mia scelta è funzionale a una fiction a lieto fine, che esprime in realtà più una speranza che una certezza, dato che finora in America Latina le élite, anche se talvolta battute a livello elettorale, non hanno mai perso il controllo sull’economia.
Il titolo che ho scelto, La ballata dei destini incrociati, vuole indicare l’intreccio di esistenze di donne e uomini che vivono, amano, combattono nel corso di un lungo lasso di tempo, dai nonni ai figli, ai nipoti; esseri umani che si rincorrono da un paese all’altro, da un continente all’altro, a significare che la ricerca della giustizia, della fratellanza, della libertà non ha confini, e si esalta in un abbraccio tra popoli diversi.
Via via che scrivevo mi accorgevo che davo più importanza alle figure femminili rispetto a quelle maschili. Non è stata una scelta voluta in partenza. Credo che lo sviluppo in tal senso di questo mio scritto sia dovuto alla consapevolezza che, nonostante il significativo avanzamento della condizione femminile da alcuni decenni a questa parte, sono le donne a sopportare il peso maggiore della trasformazione dei rapporti fra i sessi e dei cambiamenti sociali in atto in ogni parte del mondo.
Bruno D’Avanzo
La ballata dei destini incrociati, Hermatena, 2023, pp. 220, € 19,00
Fino ad ora, i messaggi di Bruno D’Avanzo sono stati diretti e d’attualità. A sorpresa si affida all’invenzione letteraria e pubblica questo romanzo, senza che per questo cambi l’orizzonte di quanto gli sta a cuore comunicare. Ci rallegriamo vivamente con lui ringraziandolo di tutto e augurando un successo non solo materiale al suo libro, così ricco di opportunità di riflessione interiore.